#cinema bellico
Text
Mosul è un film d'azione bellico americano in lingua araba del 2019 scritto e diretto da Matthew Michael Carnahan. Il film si basa sulla battaglia di Mosul del 2016, che ha visto le forze governative irachene e gli alleati della coalizione sconfiggere l'ISIS che controllava la città dal giugno 2014.
Il film è stato presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia 2019 ed è stato distribuito su Netflix il 26 novembre 2020.





5 notes
·
View notes
Text
[...]
Leggere sui maggiori quotidiani e siti di cinema recensioni entusiastiche per il film della Cortellesi obbliga, a mio modesto avviso, ad una duplice considerazione consequenziale.
La subalternità dei critici alle logiche produttive e distributive, dunque alle ragioni del mercato; l’inevitabile abbassamento delle qualità analitiche dei suddetti critici e la loro progressiva incapacità argomentativa, derivante da un ridimensionamento della complessità culturale e dell’indagine dell’oggetto artistico, cui far riferimento.
Un deserto di ricerca e di studio che diventa inesorabilmente propedeutico alla oramai acclarata mediocrità del cinema (e del teatro) italiano.
Un cinema costruito per lo più su nepotismo e caste. Sul botteghino e sugli incassi. Sulla moderazione tematica e sugli equilibri politici. Su codici liberal e sintassi postmoderne.
Fatte or dunque queste doverose premesse, veniamo più precisamente al film della Cortellesi.
L'”opera prima“ dell’attrice romana risulta, sin dai primissimi quadri, un irritante concentrato di cliché senza alcuna potenza espressiva.
Enfatico nella proposizione delle scene topiche, prontamente appesantite da sottolineature recitative e registiche, finisce coll’apparire stucchevole nel suo quasi arrogante didascalismo “di sinistra”. Un film banale sul versante drammaturgico e slabbrato su quello stilistico.
Incapace di dosare commedia, cifra grottesca e dramma sociale, la regista/attrice romana sbanda paurosamente nell’impostazione linguistica, mandando fuori giri la pellicola anche sul terreno recitativo.
Dalla palude della mediocre caratterizzazione e dell’enfasi mimico-gestuale che coinvolge un po’ tutti i protagonisti, si salvano solo alcune figure comprimarie e Romana Maggiora Vergano (la figlia Marcella).
Valerio Mastandrea dal suo canto oscilla tra l’incoerenza dei registri mentre la stessa Cortellesi è costantemente sopra le righe. Ma il problema, come dicevamo, sta nel manico che imposta la regia.
Mescola – la Cortellesi – stilemi neorealistici e registri onirico/surreali; tuttavia, non essendo né Rossellini né Buñuel, sortisce effetti destabilizzanti se non addirittura ridicoli.
Emblematica, in tal senso, è la scena fuori dalla carrozzeria di Vinicio Marconi quando, colta da improvvisa pulsione, Delia – il personaggio della Cortellesi – fa dono, al suo vecchio innamorato, di una tavoletta di cioccolata americana.
La regista cala tutta l’inquadratura in un’ insopportabile atmosfera di rarefazione trasognata che risulta involontariamente grottesca e simile ad uno spot dei Baci Perugina.
Si aggiunga poi, a tutto ciò, un bianco e nero ineffettuale e pleonastico nel suo intento puramente calligrafico e il melange indigesto è servito.
Attesa pertanto tale imbastitura linguistica, il tema centrale del lavoro autoriale della Cortellesi, ovvero il patriarcato e la conseguente violenza di genere, si smarrisce e depotenzia proprio tra i rivoli dell’incertezza stilistica.
Le scene di violenza fisica e verbale – che pur si preannunciano con il loro carico di brutalità maschilista – tra squinternati balletti, incursioni buñuelliane sul terreno del surreale, dialoghi sul filo di un grottesco che non riesce mai a risolversi in una chirurgica critica del patriarcato – sottoproletario, borghese o piccolo-borghese che dir si voglia – naufragano malamente tra le onde del pedagogismo di basso profilo, dell’insensatezza e, purtroppo, del macchiettismo.
Ancor più grave, poi, si rivela l’ambientazione sociale scelta dalla Cortellesi.
Una famiglia del sottoproletariato urbano post bellico, con immancabili aspirazioni piccolo-borghesi, dove la violenza sembra albergare quasi per endemica necessità di classe. Mentre, tra gli strati sociali più benestanti, seppur imperi il patriarcato, quella prepotenza si risolve in mere declinazioni verbali ed anche notevolmente smussate.
Uno stigma classista che non fa certo onore ad un’attrice che ha sempre voluto distinguersi per le sue idee progressiste.
In tal senso, ancor più sconcertante risulta il finale. Laddove lo spettatore si attenderebbe una fuga d’amore con l’innamorato dei tempi giovanili per sottrarsi alle violenze domestiche, Delia fugge sì, ma… al seggio elettorale.
Per votare, nel Giugno del 1946 – quando finalmente le donne ottennero per la prima volta in Italia il diritto di voto – e scegliere tra Monarchia e Repubblica.
Un gesto che dovrebbe simboleggiare, nelle intenzioni dell’autrice, la presa di coscienza politica ed esistenziale delle donne italiane. Nonché un gesto di ribellione, emancipazione e liberazione.
Se non fosse una tragica ingenuità ci sarebbe da ridere. Una simile illusione poteva darsi nell’immediato dopoguerra, all’indomani della dittatura fascista. Oggi, nel presente del film, il voto, declinato al maschile o al femminile, è un’irrimediabile truffa. Poco democratica e molto oligarchica.
[...]
1 note
·
View note
Video
youtube
Dante Maggio dall'avanspettacolo al cinema e alla TV, istinto irrequiete...
Sin da ragazzo calca le tavole del palcoscenico, diventando uno dei nomi di punta della scena napoletana: è - insieme alla sorella Pupella - il più famoso dei fratelli Maggio. Apprezzato dal pubblico e talvolta anche dai critici, Dante Maggio crea figurine saporose con le sue battute autenticamente salaci e in virtù di una grintosa disinvoltura sulla scena. Di carattere ribelle e impulsivo, da giovane finisce in riformatorio e prima di accedere ad una certa notorietà si inventa un sacco di mestieri, da gelataio a strillone, da falegname ad attrezzista nella compagnia teatrale del padre, la Maggio-Coruzzolo-Ciaramella, nella quale poi debutta come attore pur interpretando brevi battute. Ma è proprio con il padre Mimì che si fa le ossa prima di passare con Achille Maresca a recitare accanto a Raffaele Viviani e ottenere un lancio da vero attore con Anna Fougez. Nella stagione 1937-38 è a Napoli e partecipa ad alcuni sketch con Dapporto in Visi e maschere, poi lavora a Roma durante il periodo bellico in Quello che bolle in pentola e In picchiata sui cuori; quindi recita con il fratello Beniamino nell'immediato dopoguerra in Se il mondo fosse quadrato. L'avanspettacolo è il settore al quale Dante Maggio si sente più vicino e, forse a causa del suo carattere bizzarro e ribelle, perde moltissime occasioni per un vero salto di qualità con la Osiris, la Riccioli-Primavera, De Filippo. Nella stagione 1947-48 è in ditta con Vera Nandi in una rivista di un certo successo, Siamo ricchi e poveri, di Pisano, poi è con la sorella Pupella e Vera Rol ne La bugia del giorno di Amendola e Maccari, con il fratello Beniamino in Scugnizzi e femmine e Riso... dolce, entrambe del 1949; cui fa seguito nel 1951 Napoli non è milionaria nella quale fa debuttare il piccolo mulatto Angelo, da lui adottato dopo la guerra. Il dopoguerra vede Dante Maggio debuttare nel cinema, dopo un infelice inizio nel 1940 con un film di scarsa distribuzione. Ed è proprio nel cinema che Dante si costruisce un'onoratissima carriera anche se viene adoperato in ruoli di contorno o di carattere, spesso di una certa importanza, altre volte convenzionali. Sempre più assorbito dal cinema che gli offre ottime occasioni, Dante dirada le sue apparizioni in teatro non prima di aver riunito la famiglia artistica dei Maggio, tranne Pupella, per l'unica e sola volta nella rivista Venere con i baffi. Riesce anche a far scritturare il figlio adottivo, il piccolo Angelo Maggio, come protagonista nei film Il mulatto e Angelo tra la folla, entrambi diretti da Francesco De Robertis nel 1950, i quali ottengono una tiepida accoglienza. Attivo anche in televisione, appare con il fratello Beniamino nella versione per il piccolo schermo di Rinaldo in campo per la regia di Garinei e Giovannini (1963) e, negli anni sessanta, secondo la moda del momento, appare in alcuni western all'italiana con lo pseudonimo Dan May. Fra le sue ultime interpretazioni l'originale televisivo Diagnosi nell'episodio Per un bambino diretto da Mario Caiano (1975).
#recitazione #news #photography #estate #bhfyp #photooftheday #natura #commedia #instalike #televisione #live #anni #rai #mare #animazione #party #spettacoloteatrale #amore #followme #photo #attrice #palcoscenico #performance #festival #risate #actors #theater #passione #video #foto #spettacolo #teatro #show #italia #italy #musica #arte #instagood #theatre #love #cinema #like #attore #roma #eventi #cultura #art #tv #attori #picoftheday #danza #instagram #film #follow #music #dance #napoli #divertimento #actor #milano #roma #napoli
1 note
·
View note
Text
Lecco: La mostra “Futuristi. Una generazione all’avanguardia” a Palazzo delle Paure

Lecco: La mostra “Futuristi. Una generazione all’avanguardia” a Palazzo delle Paure.
Dal 18 marzo al 18 giugno 2023, il Palazzo delle Paure di Lecco ospiterà la mostra “FUTURISTI. Una generazione all’avanguardia” che indaga la presenza di linguaggi d’avanguardia nell’Italia dei primi decenni del Novecento.
L’esposizione, curata da Simona Bartolena, prodotta e realizzata da ViDi cultural, in collaborazione con il Comune di Lecco e il Sistema Museale Urbano Lecchese, travel partner Trenord, si concentra sull’esperienza futurista, nelle sue molteplici espressioni, attraverso le opere dei suoi più celebri rappresentanti, da Giacomo Balla a Luigi Russolo, da Gino Severini a Enrico Prampolini, da Filippo Tommaso Marinetti ad Antonio Sant’Elia, da Fortunato Depero a Tullio Crali, a molti altri ancora.
Il Futurismo ha saputo portare la sua ventata di novità e rivoluzione nelle arti visive, nella letteratura, nella musica ma anche nel vivere quotidiano.
La rassegna racconta, nelle sue diverse declinazioni, uno dei movimenti d’avanguardia più importanti d’Europa, nato e sviluppatosi in Italia, e i suoi rapporti con la scena europea e con la società italiana del tempo. Il percorso espositivo, suddiviso in sette capitoli, propone una panoramica coinvolgente sugli esiti noti e meno noti del movimento e si apre con la sezione che ripercorre le origini del movimento, a partire dal 20 febbraio 1909 in cui sulle pagine del quotidiano francese Le Figaro, Filippo Tommaso Marinetti pubblicò un articolo intitolato Le Futurisme nel quale con toni accesi e provocatori, caratteristici della sua prosa, propugnava la necessità di una rivoluzione, per distruggere ogni “passatismo” e per lasciare finalmente spazio al “nuovo”.
Il racconto prosegue indagando la relazione tra il Futurismo e il primo conflitto bellico mondiale quando i futuristi sostenevano il credo interventista, sperando in un sensibile miglioramento delle condizioni della Nazione grazie alla politica imperialistica. Una splendida tela dedicata a Francesco Baracca di Plinio Nomellini offre anche occasione per riflettere sul rapporto dell’avanguardia futurista con il Divisionismo.
Un focus è dedicato anche al ruolo che il Futurismo ha avuto nella nascita dei nuovi linguaggi sperimentali di inizio secolo scorso, in particolare con il Cubismo, anche attraverso la figura di Gino Severini, vero e proprio trait d’union tra i due mondi.
Un interessante approfondimento, finora poco indagato, è riservato anche alla presenza di ipotesi astrattiste nella produzione italiana, con opere di autori quali Giacomo Balla e con una parentesi dedicata agli astrattisti comaschi quali Manlio Rho, Mario Radice e Carla Badiali e al loro rapporto con Marinetti.
La rassegna lecchese passa quindi ad analizzare una delle istanze più innovative del linguaggio futurista in pittura, ovvero quella di riprodurre un oggetto in movimento, collocando lo spettatore di fronte a una composizione in divenire, sollecitandone sensazioni dinamiche, attraverso una serie di lavori di Luigi Russolo, Roberto Iras Baldessari, Giulio D’Anna e altri, nei quali i concetti di dinamismo, simultaneità e compenetrazione dei piani visivi sono particolarmente evidenti.
Lungi dall’essere considerato solo un movimento artistico, il Futurismo si apriva a un dialogo con le altre forme espressive, dal cinema alla letteratura, dalla musica al teatro, dalla cucina alla moda, pubblicando tra il 1909, data della fondazione del gruppo, e il 1916, oltre cinquanta manifesti che si occupano dei più diversi linguaggi. La sezione Un universo futurista, nucleo portante dell’esposizione, presenta importanti testimonianze dell’interazione con le arti applicate, la comunicazione pubblicitaria, il design, il teatro, la danza, la musica. Particolare attenzione sarà dedicata alla ricerca di Fortunato Depero e al suo rapporto con Campari e di Luigi Russolo del quale saranno esposti gli Intonarumori di Luigi Russolo.
La rassegna si chiude esaminando l’evoluzione dell’Avanguardia futurista, così come si è sviluppata negli anni trenta del Novecento dove le nuove generazioni si adeguano al nuovo clima sociale e politico, trasformando il futurismo storico in un movimento meno coerente e certamente meno utopistico e rivoluzionario, ma ancora capace di rappresentare l’attualità.
Tra le diverse correnti nate in questo periodo si distingue quella dell’Aerofuturismo, nata dalla passione per il volo aereo, e quella della visione “cosmica”, caratteristica della ricerca più tarda, aperta a suggestioni spirituali ed esoteriche, con opere di autori quali Tullio Crali, Gerardo Dottori, Giulio D’Anna, Fillìa, Thayaht, Alessandro Bruschetti, Barbara e altri.
“Negli ultimi anni - ricorda Simona Bartolena - il ruolo di primo piano nel contesto europeo di questa Avanguardia nata in Italia è stato ampiamente riconosciuto anche a livello internazionale, con importanti studi e grandi mostre nei principali musei del mondo, eppure ancora oggi la conoscenza che di esso ha il grande pubblico non è completa e approfondita. La maggior parte dei testi dedicati al Futurismo sono, infatti, focalizzati sui primi anni del movimento. Ma al primo periodo che si conclude, di fatto, con la morte precoce di Boccioni, avvenuta nel 1916, seguono altri anni ricchi di spunti di riflessione, interessantissimi quanto a novità di linguaggio e originalità di ricerca. Pur senza negare l’importanza dei primi dieci anni di gestazione, in una corretta lettura del Futurismo non si può prescindere dall’analisi anche dei due decenni seguenti. È, anzi, proprio in queste successive generazioni che il Futurismo trova la propria unicità; rispetto alle altre avanguardie europee”.
“Questa dirompete e prolungata vitalità - prosegue Simona Bartolena - permette al Futurismo di propagarsi in tutta la penisola e superare di gran lunga i confini in cui di consueto si muovono i linguaggi delle avanguardie storiche, necessariamente elitari. Pur non aderendo al sistema dell’arte ufficiale (dal quale si tenne orgogliosamente distante), il Futurismo ha saputo, soprattutto negli anni trenta, costruire a propria volta una complessa rete culturale, come alternativa straordinaria e unica nel panorama europeo alle tendenze più in voga. La mostra vuole esplorare anche questi aspetti, oltre che raccontare, più in generale, il movimento di Marinetti”.
Così l’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “Continua il percorso promosso da ViDi cultural, in collaborazione con l’amministrazione comunale per l’esposizione delle grandi mostre di Palazzo Paure, nel viaggio che ci accompagna tra ‘800 e ‘900 che giunge così ai primi anni del 900 con i linguaggi d’avanguardia, ovvero del futurismo. Una mostra importante che raccoglie opere significative anche sul panorama nazionale e internazionale, con la possibilità di essere un evento attrattivo non solo per i cittadini e le scuole che vi faranno visita, ma anche per un pubblico che arriverà a Lecco interessato a frequentare e visitare la nostra città in termini di partecipazione e turismo culturale”.
L’iniziativa è il secondo dei cinque appuntamenti di Percorsi nel Novecento, programma ideato dalla Direzione del Sistema Museale Urbano Lecchese e affidato per la sua progettazione e realizzazione a ViDi Cultural che, fino a novembre 2024, analizzeranno la scena culturale italiana nelle prime sei decadi del XX secolo....
#notizie #news #breakingnews #cronaca #politica #eventi #sport #moda
Read the full article
0 notes
Text
Ai Bafta nomination record per l'antibellico 'Niente di nuovo sul fronte occidentale'
Niente di nuovo sul fronte occidentale, il film del regista tedesco Edward Berger, tratto dal capolavoro anti bellico sui disastri psicologici della Prima Guerra mondiale di Erich Maria Remarque, ha avuto 14 nomination, tra cui miglior film e miglior regista, ai premi Bafta, gli Oscar inglesi, annunciate oggi. E’ stato il film in lingua straniera con più candidature nella storia del cinema…

View On WordPress
0 notes
Text
Giorni d’estate, una storia di sentimenti sullo sfondo del dramma bellico
Giorni d’estate, una storia di sentimenti sullo sfondo del dramma bellico
Arriva nei cinema il 25 agosto la prima opera cinematografica per la regia di Jessica Swale, premiata sceneggiatrice…
Un film che si pone la sfida di trattare temi contemporanei proiettandoli nella durezza degli anni ’40, ma che è soprattutto una storia di sentimenti universali ambientata nella placida bellezza della campagna inglese. “Giorni…
Read MoreCinemaToday
View On WordPress
0 notes
Text
FROM HELL E V FOR VENDETTA DAI FUMETTI AL CINEMA
FROM HELL E V FOR VENDETTA DAI FUMETTI AL CINEMA
Il fumetto americano vive di eroi in costume rivestiti di colori sgargianti, il fumetto inglese ha una tradizione diversa, fatta di vecchi tascabili a sfondo storico o bellico, di serie fantascientifiche e spionistiche.
Lo sceneggiatore inglese più significativo degli ultimi vent’anni, Alan Moore, ha costruito la propria carriera rielaborando a livello più adulto e complesso gli archetipi del…

View On WordPress
0 notes
Link
I tre stadi dell’elaborazione del trauma in Italia:
Rifiuto
Mercato
Golpe
L’avvocato Giuseppe Conte, che nessuno ha mai votato, nessuno ha mai eletto, nessuno nemmeno conosceva prima che diventasse premier, è apparso a reti unificate ed ha decretato lo stato d’assedio in tutto il paese, nel plauso unanime di maggioranza, opposizione, Confindustria, e media mainstream.
Chiusura obbligatoria su tutto il territorio nazionale di scuole, università, musei, cinema, teatri, ristoranti, alberghi, discoteche, stadi, e di quasi tutti i negozi.
Ma non delle fabbriche.
Stop al campionato di calcio e alla celebrazione delle messe.
Ma non ai cantieri.
Parlamento ridotto al minimo. Elezioni amministrative e referendum rimandati a settembre.
Vietato spostarsi, vietato riunirsi, vietato uscire di casa se non per fare la spesa, o andare al lavoro per contribuire allo sforzo bellico, come si dice in tempo di guerra.
Vietato assentarsi.
E vietato ammalarsi, perché il nostro sistema sanitario non può curarci tutti, non ha i fondi, il personale, le attrezzature, i posti letto.
Se ci ammaliamo in troppi, ai medici toccherà scegliere chi salvare, come in tempo di guerra.
Come siamo arrivati a questo punto?
Un passo alla volta.
Un taglio alla volta.
Una Sanità pubblica dissanguata dai tagli al bilancio, trattata per decenni come una Bad Company da rottamare.
Rifiuto in nome del Mercato.
Guai ad ammettere le inevitabili conseguenze di decenni di politiche criminali.
Guai a spaventare i turisti, gli investitori, la Borsa.
Poi golpe bianco, mentre il contagio è già fuori controllo, e l’Europa ci sbatte la porta in faccia, nel vano tentativo di evitare una sorte analoga che gli sta già capitando.
Golpe “necessario”, ben riconoscibile sotto la mascherina, ma che in pochi osano contestare apertamente, perché l’alternativa fa più paura.
Pestilenza.
Il Cavaliere dell’Apocalisse che governa il mondo in una coalizione di larghe intese con Guerra, Carestia e Morte.
2 notes
·
View notes
Text
“La poesia ci ha salvati: è stata la nostra rivoluzione, più degli elicotteri gabbiani negli schermi in bianco e nero del cielo di Saigon. Se c’è stato qualcosa, dopo gli anni Sessanta, che abbia permesso all’Italia di resistere al suo più grande nemico – se stessa, l’incubo di un’identità mancata e di una democrazia incompiuta e sempre rinviata – non è stato il pensiero o la politica, le grandi inchieste o il romanzo: no, è stata davvero la poesia, insieme alla poesia del cinema. Sono i versi che hanno stretto in un abbraccio l’Italia al termine del suo sogno post bellico di sviluppo. È la poesia che ha trovato una fedeltà contadina, una lingua comune e ha vietato la stupidità macabra della fine della letteratura, negando l’ipocrisia, l’invidia sociale, offrendo a poeti immensi di essere davvero i poeti di una nazione ferita”
QUI
19 notes
·
View notes
Text
DI ANTICOMUNISMO, SINISTRE DI DESTRA E ALTRO

La ribellione del villaggio Napaken contro i colonialisti francesi (Museo provinciale di Savannakhet)
C`e` un tema importante che ho riscoperto arrivando a Savannakhet, quello delle memorie dei conflitti. Vivo in una cittadina, Luang Prabang, che ha una storia filomonarchica abbastanza delineata. La figura del Re ancora oggi serve ad alcuni per ricordare un passato migliore del presente. E` soprattutto un baluardo anticomunista oltre che un'istituzione potenziata dalla colonia francese per facilitare il controllo locale. Tra i racconti preferiti dai turisti che non vedono l`ora di scoprire qualche segreto laotiano ci sono, ad esempio, le storie degli autisti del re finiti in campi di rieducazione e probabilmente morti li`. L`aristocrazia della citta` si e` invece rifugiata all`estero, negli USA e in Francia, soprattutto. Alcuni di loro sono ritornati nella terra degli ancestri per cercare radici spesso nascoste da un hotel o da un centro massaggi o da un ristorante. Non esiste pero` un racconto scritto o per immagini della guerra civile in città. Si possono ascoltare storie ma il superamento del trauma bellico a Luang Prabang e` stato trainato dall`industra turistica ed ha prodotto un radicale spostamento della critica rivoluzionaria allo sfruttamento coloniale, al suprematismo bianco o all'ingerenza di entità economiche sovranazionali, verso una meticolosa revisione indigenista della storia locale per fini commerciali e recentemente anche anticinesi.

La presa di Atsaphangthong (vicino Savanakhet). Museo Provinciale di Savannakhet
Savannakhet sorge invece in una storia contesa a partire da un tentativo mai completato di cancellazione delle reminiscenze militari della citta`. Come accennavo nel messaggio su telegram di ieri, la citta` tutta fa parte di un grande rimosso, di una guerra segreta combattuta su vasta scala, di cui si sa molto poco ma che fornisce spunti per comprendere altre guerre, combattute su altre geografie forse con strategie militari assimilabili. Da un punto di vista sociologico, l'elemento piu` interessante che ho trovato riguarda gli spazi del divertimento militare, ma sarebbe meglio dire paramilitare, cosi` profondamente legati alla ricerca dell`oblio e del non riconoscimento dell`Altro. Le accoglienti fumerie di oppio e di eroina, i prostiboli appartati, le strade strette e le poche finestre verso `fuori` degli edifici creano dei luoghi perfetti per l`intimo e personale superamento della soggettivita`. Qui l`annullamento avveniva con discrezione e permetteva facilmente di spingersi fino alle estreme conseguenze piu` distruttive, da quelle del sè come il suicidio o la perdita di ragione, a quelle dell'altro da sè, come lo stupro, la pedofilia e altro ancora. Questa possibilita` di perdersi era per così dire facilitata proprio dalla non esistenza di Savannakhet e della base militare americana non lontana. Ogni epistola o racconto ufficiale disponibili negano oppure omettono questo "dettaglio" producendo un senso di impunità storica dell'impero.

Vorrei allora raccontare come questa non esistenza e questo perdersi sono stati reinterpretati attraverso le testimonianze architettoniche di due cinema. Il primo, qui sopra, era il cinema ``americano``. Costruito alla fine degli anni `50 in stile post art-deco`, era utlizzato dai soldati in licenza per diversificare il loro divertimento. Dopo la guerra e` rimasto inutilizzato fino a un anno fa quando e` partito un progetto di restauro che gli ha dato nuova vita attraverso una caffetteria, un ristorante vietnamita e un negozio di fotografia e di abbigliamento fashion.

È servita una lunga opera di convincimento dei quadri locali del Partito per riaprire al pubblico un ex cinema che molti consideravano un`icona da cancellare del passato colonialista. Al suo posto, per eliminare anche la memoria di svago associata alle ore di proiezione di film stranieri, negli anni '80 fu costruito un altro cinema, questa volta con architettura sovietica, voluto dal consulente russo del Partito che si trasferì a Savannakhet alla fine della guerra. Si trova a soli due isolati da quello americano e in qualche modo voleva ribadire la rovina del vecchio e la vittoria del nuovo.

A Luang Prabang non ci sono cinema (c`e` un teatro che non ha mai avuto funzione di cinema). Nella capitale del Laos, Vientiane, e` stato aperto un multisala ipermoderno dentro un centro commerciale pochi anni fa in cui si proiettano film borghesi tailandesi e alcuni blockbuster holliwoodiani. In una cittadina nel Laos centrale, di non piu` di 100.000 abitanti ci sono invece ben due cinema d'essai, di cui uno, quello russo, prima che si fondesse il proiettore, anche funzionante. Il ritrovare questi cimeli di una guerra non raccontata, insieme ad un piccolo museo che si azzarda a mostrare le immagini di una guerriglia contadina armata di braccia e baionette contro gli aerei americani, mostrano un Laos completamente assente in una citta` monarchica come Luang Prabang, o rivolta al capitale come Vientiane. Fuori dai mondi del turismo educati se non dall`anticomunismo, certamente dalla sua sconfitta storica avvenuta nel 1989, si riscoprono genti nei margini, orgogliose di un cinema sovietico e di un ex cinema americano ora adibito alla cucina vietnamita e alla degustazione di caffè locali.

E` proprio a partire da questa consapevolezza che in citta` si articola, a mio parere, un movimento urbano che sta ricostruendo il passato oltre "l'invenzione delle tradizioni" ma in bilico tra un discorso "comunista inattuale" e il bisogno di connettività col resto del mondo "social". Per due generazioni i temi che riguardavano la guerra civile sono stati trattati con estrema difficolta`, sia per i traumi personali che si erano vissuti, sia perche` si temeva di raccontare visto che non tutta la guerra era terminata. Lo scontro sucessivo all`uscita degli americani riguardo` infatti regolamenti di conti molto locali, tra fascismo ed antifascismo e molteplici gradazioni riscontrabili in aree piu` remote dove la partecipazione alla guerra segui` soprattutto reti familistiche e appartenenze di clan piuttosto che vere e proprie ideologie e visioni del mondo. Tutto cio` ha prodotto una relazione profondamente paronoide con la vita pubblica che le nuove generazioni stanno provando a mettere in discussione. Per farlo, riutilizzano e contaminano di idee globali spazi chiusi da tempo in modo da trattenerli prima che li scopra il capitale. Simultaneamente la città si sposta e mentre il cinema russo col suo proiettore fuso e le sue scomode sedie di legno attende una modernizzazione da multisala, il vecchio cinema americano si rifà il trucco e diventa incubatore di imprenditoria giovanile e delle leggi del mercato. Qui spiccano nuove eroine del femminismo neoliberale o capitalista come quelle rappresentate nella foto in basso, esposta nel ristorante "non vegetarian friendly" dell'ex-cinema.

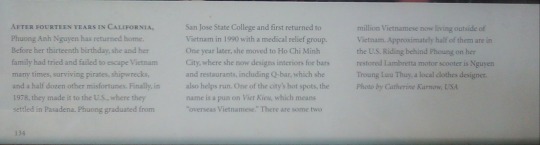
0 notes
Photo
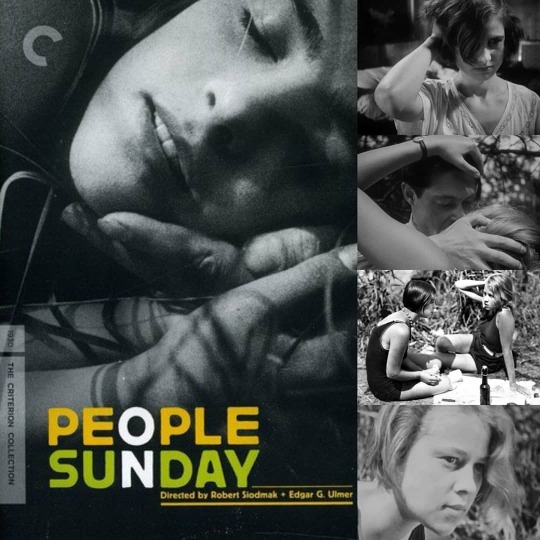
#Peopleonsunday di Robert Siodmak ed Edgard G.Ulmer avvalendosi di una narrazione fluida, mirata al realismo, si attesta come un pionieristico studio sociale che fece epoca partendo da un'idea embrionale di Billy Wilder. È un film sperimentale che si serve di uno stile documentaristico per raccontare il tempo sospeso della Berlino di Weimar. Il film segue per 24 ore la vita di 5 impiegati berlinesi interpretati da attori non professionisti, catturati nell'unico giorno della settimana in cui potevano essere liberi e spensierati, la domenica. Siamo di fronte ad un interludio bucolico che neutralizza per un attimo il trauma della sconfitta del primo conflitto bellico. Nella spensieratezza di questi cinque berlinesi c'è l'incanto di un'estate che non potrà mai più essere replicata. Così il cinema inizia a riprodurre la vita estrapolandola dal tempo per fermare per un attimo un ritorno alla pace che con l'ascesa di Hitler sembrava essere una chimera. #cultmovie #criterioncollection "Se fossi in te, farei un po' di scena" https://www.instagram.com/p/CH76DMZlcGL/?igshid=1fhrfsuyrdk3x
0 notes
Text
Animazione/12: I Dinamite

I Fratelli Dinamite (Nino Pagot, 1949)
Un film più importante che bello, "I fratelli Dinamite" è la prima animazione italiana proiettata sugli sgangherati schermi di una nazione appena uscita, rovinosamente, dalla guerra. Per corollario, è anche il primo film italiano a colori.
Fissato il paletto che lo rende, già solo per questo, un’opera seminale e prima pietra di una cinematografia che non ha prodotto nel tempo quanto sembrava promettere, i Dinamite è una storia avvincente, sia in senso diegetico sia storicamente: la loro genesi incerta, l'anteprima a Venezia, e la prima proiezione, durante il Natale del 1949, fallimentare. Che si tratti del primo film animato italiano è stabilito dal marchio SIAE di deposito: il numero 672 del 1947. Il suo concorrente, "La rosa di Bagdad" di Anton Gino Domeneghini, numera invece 799, e l’anno è il 1949.
Entrambi furono proiettati in anteprima durante la Mostra del Cinema di Venezia del 1949; entrambi erano arrivati sani e salvi in porto, o meglio in laguna, dopo le ovvie disavventure legate alla Guerra, tant’è che, in luogo di una data di produzione, essi esibiscono una cronologia, misurando la quale ne risulta che il film dei Pagot fu iniziato dopo e finito prima (1943-1947), mentre quello di Domenighini iniziò prima e fu registrato dopo (1942-1949). Tale tempismo rende il giusto tributo ai Pagot, autori di maggiore caratura, di un’opera decisamente più complessa, fortemente nazionale nei contenuti, più legata a usi, costumi, idioletti e architetture nostrane, che si contrapponevano all’ennesima variazione sul tema, pertanto molto gradevole, delle "Mille e una notte", in una Bagdad orgoglio di un mondo esotico e magico, non ancora bombardata a tappeto.
La complessa famiglia Pagot, Nino in primis e suo fratello Toni, supportati più avanti dai figli di Nino, Marco e Gi(na), focalizza interesse sugli esperimenti animati già dagli anni ’30, e nel 1938 i due fratelli fondano una loro casa di produzione che, nel periodo bellico, è impegnata giocoforza a produrre animazione di propaganda di un regime ormai condannato. Grazie a tale patto, però, i Pagot ebbero la possibilità di continuare i loro lavori, le loro ricerche, gli studi sui carachter design che si sostanziarono nel mediometraggio "Lalla, piccola Lalla" (terminato nel 1946). La biondissima tenera e paciocca bambina con la testa grande e la calzamaglia, insieme a Paolino (lo studente secchione) e al cicciottello senza nome, li ritroveremo attori non protagonisti del nostro film.
Ancora: in quel periodo, i Dinamite rischia di vedere la luce come cortometraggio che avrebbe avuto il nome del protagonista, Tolomeo. In effetti, oltre alla sostituzione del singolo con un trio, il film si strutturerà in episodi, anche abbastanza difformi tra loro.
Per questa prima produzione italiana, i fratelli Pagot si avvalgono dell’opera di un già adulto Osvaldo Cavandoli: il padre della mitica "Linea" è un ventisettenne che qui muove i suoi primi passi come intercalatore. A dar manforte si affiancano Osvaldo Piccardo e Ferdinando Palermo, quest’ultimo nel doppio ruolo di capo-animatore e responsabile del sincrono. In ultimo, abbiamo cura di ricordare un personaggio normalmente dimenticato o nel migliore dei casi sottovalutato, quel Giuseppe Piazzi che ha sicuramente composto tutte le musiche del film e che è depositario SIAE sia degli arrangiamenti delle canzoni popolari veneziane utilizzate nell’ultimo episodio, sia di tutti i testi delle canzoni originali presenti lungo tutta la storia, assegnazione che nei titoli di testa è appannaggio di Palermo. Siccome è bello fare giustizia, soprattutto di personaggi poco baciati dalla fortuna, ho riportato qui un sunto dei frutti dell’investigazione di Marco Bellano, cui rimando la lettura del saggio, in bibliografia. Tale dilungarsi non è solo desiderio di giustizia: vuole riconoscere il ruolo centrale della musica in questo film che, senza i testi, gli arrangiamenti e le partiture di Piazzi sarebbe stata povera cosa.
E ora, il film.
L’età dell’oro?
Quella che Bendazzi, nella sua monumentale opera definisce come "l’età dell’oro" dell’animazione mondiale, il periodo 1928-1951, in Italia ne è appena la culla, quel 1949 già prossimo al declino, dopo una totale indifferenza e i primi passi in una Nazione in guerra.
I Dinamite, come già ricordato, fu pensato come un cortometraggio.
Un’idea comprensibile, in un momento storico confuso, con mezzi scarsissimi e la cui unica possibilità di commercializzazione "pronto cassa" era rappresentata dall’abbinamento di un corto a lato di un lungometraggio, possibilmente interpretato di divi "in carne e ossa", sia pur ingessati dall’autarchia e dal moralismo bellico. Il passaggio storico, dalla censura all’invasione nordamericana i cui echi, le Star e il Jazz, non erano ignoti a una minoranza "colta" e sovversiva, comunque poco rappresentativa delle grandi masse, provocò un terremoto sul quale con grande difficoltà si muoveva un’opera marchiata da un passato da dimenticare e, paradossalmente, troppo moderna. È pur vera che tale invasione fu temperata dalla stagione del Neorealismo (che fece illudere addirittura un’invasione al contrario), ma il confronto tra lo splendore del technicolor, su cromie cangianti e agili, arricchite da musica e canti, poco si addiceva ala poetica de "la vita così com’è", in rioni popolari, distrutti dalle bombe e governati dalla fame. Tale discrasia aggiunse un ulteriore biais che si sostanzierà nel flop commerciale del 1949, e nel dimenticatoio presso cui il film sarà costretto fino al suo restauro.
A onor del vero, nel 1971 fu provato un lancio televisivo, nell’ancora sperimentale Rai2: "I fratelli Dinamite" è trasmesso in prima serata, naturalmente in b/n.
Bisognerà attendere il 2004, l’anno del restauro curato dalla Cineteca Italiana e vari sponsor, quando infine, da due vecchissime copie in nitrato, sarebbe stata tirata una versione luccicante che inaugura la LVI Mostra di Venezia.
E siamo a oggi, con le copie in DVD e gli streaming a portata di mouse.
Siamo in tre!
In realtà siamo in sei, i sei episodi che ripercorrono la vita di Din, Don e Dan, i pestiferi Dinamite, da appena nati all’adolescenza, fino a quell’atto finale con cui, "dopo aver lambito l’Inferno", si saranno assicurati un posto in Paradiso.
Riassunto così, il film sembra invitare a toccar ferro, lasciando immaginare che la fine della storia coincida anche con la fine di quelle tre giovanissime vite. Non era certo questa l’intenzione dei Pagot, ma una certa deriva "deamicisiana", a volte, sembra farsi prendere la mano, come questo finale patetico-ammonitore che fa il paio con la terribile reprimenda del bidello al secchione Paolino, che per poco non si era lasciato irretire dai pifferi infernali (inutilmente, ci cascherà comunque). Il tono bonario ma deciso, insieme patetico, supplichevole e intimidatorio del brav’uomo lo accostano più decisamente al libro Cuore che alla saggezza pedante del Collodi, e il tono di questi due piccoli episodi ricordano le pagine strappalacrime della malattia del Muratorino, o l’agonia della Piccola Vedetta Lombarda.
Come ricordato, il nostro film attinge, a piene mani ma declinando a modo suo, al lungo patrimonio della tradizione culturale italiana, di cui fa parte anche quel libro angoscioso. Altre referenze, più brillanti, più oggettive, le vedremo in corso d’opera. Conviene perciò ritornare ai sei episodi, e alla loro strutturazione.
Nel primo episodio, i tre fratelli sono ospiti in barca dello zio ubriacone in cerca dell’Eldorado, l’isola del Rhum di cui è ghiotto, e con cui allatta i tre neonati. L’impossibilità di tenere la barra dritta e il sopraggiungere di una tempesta causano un naufragio i cui soli sopravvissuti, a cavallo di una cassa di rhum che farà anche da alimento, sono appunto Din, Don e Dan. La corpulenza dello zio-capitano imprime da subito una costante del cinema dei Pagot: essa designa personaggi negativi, al massimo ambigui, come lo zio snaturato, il bidello angosciante, fino a Satana in persona. L’ondeggiamento della cinepresa sui "cel" in tempesta, oggi, fa un po’ sorridere, ma la resa in technicolor delle sfumature delle onde, e del movimento che esprimono, ricordano decisamente le grandi opere di Hokusai, che ai Pagot potrebbero esser state note, se non addirittura approvate dalla censura in quel tempo in cui Giappone e Italia, pur avendo idee vaghissime una dell’altra, erano state alleate. Ricordiamo infine che esiste un legame affettivo tra la famiglia Pagot (Marco e Gi in verità) e il Grande dell’animazione, quell’Hayo Miyazaki che in "Porco rosso" chiamerà proprio Marco Pagot il suo eroico aviatore.
Il secondo episodio è quello più calligrafico, per qualcuno anche il più gradevole, ma di certo il meno interessante. Potrebbe essere una classica produzione Disney: in pochi si accorgerebbero dello scambio. L’isola deserta, abitata da animali fantastici e policromi, ha tutte le caratteristiche dell’Eden, bella, felice, pacifica. Maiali-pipistrelli, uccelli multicolore, alberi delle salsicce, frutti mielosi e una mucca (o forse una bufala) che lecca amorevoli i tre bimbi nudi, dal ventre prominente e che sembrano essi stessi dei putti, piccoli angioletti. L’idillio si muove tra inquadrature pensate come pittura a olio, maestose e definitive, splendenti di technicolor e statiche: un indugio sulla bellezza che è più un indice della povertà dei mezzi e dei fondali. Il gorilla, che si muove con cadenze jazz e conosce, lui solo, il linguaggio umano, allieta gli abitanti con jonglerie che divertono tutti, anche i bambini spesso usati come palle da giocoliere. L’idillio è rotto dall’arrivo di un "comitato scientifico inglese", preannunciato dall’indizio delle sue civili orme di scarpe che schiacciano fiori e piante mentre, metodicamente e con un certo gusto dell’arte di impacchettare, cinquanta anni prima di Christo (l’artista), fanno incetta di ogni forma vivente, timbrata con le destinazioni d’uso, dallo zoo alla pellicceria. Il salvataggio della bufala, destinata alla macelleria, provoca la cattura dei tre bimbi, per mano dell’ineffabile miss Chloè, retino in mano e didietro all’aria.
Tale episodio non aggiungerebbe granché alle grandi produzioni Disney, in special modo quelle degli esordi, focalizzate sul mondo animale prima dell’azzardo, che si rivelò un grande successo, di "Biancaneve". Una grandezza giustificata, sia dai grandi mezzi a disposizione, sia da una "grammatica" dettagliatissima, che riusciva a inglobare anche il remotissimo, dal punto di visto spaziale e ideologico, utilizzo asincrono della musica, teorizzato da Ejzenstejn-Alexandrov-Pudovkin, e che nel nostro episodio non notiamo. Ma lo ritroveremo più avanti.
Il terzo episodio è di tipo frequentativo.
Serve a introdurre i fratelli nella società civile, già cresciuti e nel loro character design definitivo, segaligni, naso lungo, viso regolare, rivestiti da seminaristi, e ancora pestiferi, intenti a suggere sigari più grandi di loro e a leccare la marmellata dal pavimento. Si tratta di una interlocuzione necessaria, utile a sorvolare su alcune evidenti discrasie: sono italiani o inglesi? Sono imparentati con Chloé, sorella di "zio Rhum", o sono stati trovati e adottati? Tutto sommato, poco importa.
Pinocchio
Così potremmo rinominare il IV episodio, quando il film, finalmente, decolla.
L’eterno conflitto tra il pessimismo della volontà e l’ottimismo della ragione, tra l’educazione severa e il Paese del Bengodi, è attaccato da tre direttrici che lo faranno, letteralmente, esplodere. Esse sono: l’eversione collodiana, la polisemia musicale, il citazionismo.
Din, Don, Dan, in perenne formazione di squadriglia, che unita come un mecha giapponese assume le forme e la cazzimma di un gallo, sembrano andare volentieri a scuola. Ma, di fronte ai loro amichetti Paolino, Pierino, Lalla e il cicciottello, già catturati dai pagliacci, non esitano a mettersi nel sacco con le proprie mani. La fuga verso l’Inferno, su di un cavallo sempre più inscheletrito durante il galoppo, e che molto ricorda quello del "Nosferatu" di Murnau, fa intraveder loro le nebbie della desolazione si cui si agitano i fantasmi dei sette vizi capitali, imbrigliati di terrore e disgrazia, come ferocemente li descrisse Dante, e che sono il benvenuto alla dimora di Satana, un corpulento (cattivo, "senza pietà") collezionista di bambini che ama rivestire di fattezze animali che danno loro la fisionomia e il comportamento. E così, il già non sveglissimo cicciottello, diventa un maialino, nel mentre Pierino, il suonatore di zufolo, è ancora affascinato dai suoni jazzati e batte i piedi accompagnandone il ritmo, salvo sfuggire alla cattura grazie alla sua agilità, e far partire la rivolta, perfezionata dai Dinamite. Sale in cattedra l’eversione collodiana, di cui fu magnifico interprete Carmelo Bene che con la sua sola voce diede anima a questo fannullone, lazzarone, incantato solo dalla Bellezza superficiale, e sempre in ritardo coi pentimenti. Se possibile, i Pagot si spingono oltre, fino all’esplosione dell’Inferno. È la loro maniera di procedere: gettando l’esca del paternalismo deamicisiamo, essi stanno già confezionando i botti, lustrandone la miccia, facendo brillare l’acciarino.
La colonna sonora segue sincronica gli avvenimenti: i pagliacci cercano di irretire gli studenti con pifferi e cembali molto contenuti che poi diventano melliflui, incantatori, e riducono i corpi umani in serpenti privi d’ossa e di volontà, infine rapiti. Pur essendo tipici strumenti dionisiaci, sono usati in tutt’altra guisa, non pazzo entusiasmo ma sottile opera di convincimento, tuttavia efficaci, elegantemente sinuosi.
Il diavolo è invece un melomane, ha una debolezza per la musica che lo rende "buono", e perciò imbelle. Le musiche che lo commuovono sono ordinarie canzoni popolari, ma anche un cluster di note atonali pestate a casaccio dal suo fido gatto che cerca disperatamente di liberarsi dalla forchetta che lo tiene inchiodato al pianoforte. Il vocabolario di Satana si rivela una collazione di brani e arie tratte dalla Traviata, dall’Orfeo, dalla Norma, dal Rigoletto, fino all’omaggio alla Carmen, quando, inferocito, si trasforma in un toro alla carica, elegantemente schivato dalle sottane di Din, Don, Dan.
Trionferà lo spirito giocondo: la musica
Il V e il VI episodio a una prima occhiata non sembrano distinguersi nettamente. L’impressione è di essere comunque a Venezia, prima a teatro (e il grasso, cattivo, poliziotto, si esprime in effetti con tale accento) e poi nel più glamorous Carnevale del Mondo.
Tant’è, la divisione torna utile per considerare il V episodio come quello della musica, dispiegata al suo massimo. Il casus belli diventa un contrabbasso, il regalo ricevuto da Gesù Bambino per aver sconfitto il Diavolo. Amanti dello strumento, si propongono a una serissima orchestra di concerto borghese, che fa ala a un pianista sentimentale, ammirato dall’alto del suo palchetto da una innamorata e avvenente fanciulla.
L’attrito dell’episodio è introdotto da una fortunatissima canzoncina scritta da Piazzi ed eseguita off-air a commento dei tre fratelli che estirpano le barbe e i capelli dei "passatisti parrucconi" in nome della Gioia, Futura Umanità.
In groppa al loro strumento, che così ricorda le fattezze della loro amica bufala, salvata e poi perduta, si dirigono ottimisti nel teatro, certi di essere assunti. È indubbio che tema e svolgimento della canzoncina hanno, nel dopoguerra, creato qualche imbarazzo a un Paese che da regio-fascista si risvegliò, nell’arco di tre anni, repubblicano-democratico. L’eco futurista, le ampolle dannunziane, i coretti à la Lescano, erano senza dubbio un mobilio da confinare in cantina, più che da esibire nei cinema. In effetti, l’interesse del film consiste anche in questo, riflettere su una transizione che formalmente fu velocissima, ma che nei fatti ebbe i suoi momenti, e che non si poteva certo cancellare con un colpo di spugna.
Come sia, il trio entra nel Teatro delle Muse, dove il celebre pianista Paskuarosa terrà il suo solito, memorabile concerto.
Come nella migliore tradizione Disney, l’azzimato artista è destinato a scapigliarsi, diventare tutt’uno con la sua musica sentimentale. In panoramiche e carrelli in avanti si crea il "feeling" tra l’orchestra, in basso, e i palchi, in alto, dove le masse ondeggiano fino a quasi cadere, e dove la bella è raggiunta da fiori, baci e artifici vari che percorrono autostrade di piante, alberi, intere foreste che mettono in comunione i cuori in lacrime degli ascoltatori e quello in tumulto dell’esecutore. Se i corpi tremano, l’architettura del teatro resta immobile, come una bomboniera i cui elementi di arredo sembrano, ognuno, delle golose caramelle che sudano miele. Almeno finché non arriveranno i Dinamite, con questo strumento già di suo problematico: ingombrante e nato come accompagnamento, esso ha inaugurato vita nuova col Jazz, in cui si produce spesso in assolo poco adatti alle orecchie delicate, e che introducono, danno la carica, anche alla canzoncina dello spirito giocondo. Sardonico e insieme ipnotico, tale strumento sarebbe sicuramente piaciuto a Euripide nel mentre sceneggiava "Le Baccanti".
Ancora peggio: il detto contrabasso non ha la semplice mira di essere accettato, ma prolifera come un virus: prima contagia il pianoforte suonato coi piedi, alla maniera di Jerry Lee Lewis; poi attacca tutti gli altri, attraverso lo scambio degli spartiti che crea quell’effetto tipicamente cartoonesco per cui il violino che segue la partitura del cello diventa esso stesso un cello suonato maldestramente da un violino: "Musica moderna!", sentenzia la giovane dama del palco che, nella sua assoluta mediocrità di gusto, ha assolutamente ragione. Ancor più evocativa, più avanti, è l’ulteriore rivoluzione ormai prossima, quella elettrica, qui suggerita dall’impianto luci che fulmina una maestosa e impassibile arpa fino a trasformarla nello scheletro di un dinosauro gobbo, "passatista".
Il teatro dell’Arte - Le canzonette
E infine arriviamo al Carnevale.
L’episodio, dopo Collodi, l’opera lirica, Dante & De Amicis, (per tacere del Futurismo), si arricchisce di due ulteriori tasselli che avrebbero, insieme agli altri, potuto concorrere alla genesi di un cinema di animazione italiano più prestigioso di quanto sia effettivamente diventato.
Essi sono la Commedia dell’Arte, con le sue maschere e psicologie, e la canzone popolare.
Questa è protagonista, attraverso gli arrangiamenti del Piazzi, delle esibizioni canore dei concorrenti al titolo di "Dogi del Carnevale", padroni assoluti "fino al Giorno del Giudizio". L’esibizione che precede quella dei Dinamite è eseguita in una tinozza sulla laguna da tre fresconi che modulano falsetto, baritono e tenore non solo nella vocalità ma anche negli strumenti, come una delle migliori gag degli "Amici miei", molti anni dopo. Con minor fortuna, affondano.
I Dinamite, scorrettamente, si affidano al playback de "La biondina in gondoleta", mimandone i trasporti emotivi che coinvolgono un pubblico trasognato che li incorona vincitori. Inseguiti e portati in trionfo da mille maschere compatte e multilineari che vanno su e giù per le calli, esprimono le vertigini di un Otto Volante, quando l’adrenalina ti ordina solo di fuggire. Saggia decisione, poiché l’entusiasmo delle masse si trasforma in una caccia senza quartiere quando i fratelli ordinano, come primo atto legislativo della tirannia loro assegnata, di sospendere le feste "fino a quando non si sarà ritrovata la bambola perduta" di una bambina in lacrime sul sacrato di San Marco.
La resa grafica di colori, linee e cerchi, non muta la grafica di un tumulto che resta disordinato, possente e esplosivo, in cui la bellezza non è simmetria ma l’improvviso disvelarsi, quando tre vecchi "parrucconi" sono in realtà (oppure si trasformano in) tre leggiadre fanciulle. Una differenza strutturale con le ordinate parate di maschere e travestimenti dei grandi autori dell’Estremo Oriente, tra i quali ricordiamo almeno Oshii Mamoru in "Ghost in the Shell- Innocence" e Satoshi Kon in "Paprika".
Il ritrovamento della modesta bambola di pezza sul fondo della laguna, armati di mattone appeso al collo e candela per far luce, ha infine successo grazie alle indicazioni di un vecchio pesce che comprende solo il giapponese, e risponde in veneziano. Sicché, con questa buona azione, i Dinamite si sono guadagnati il Paradiso.
Più che una Pietra Miliare, "I Fratelli Dinamite" fu la Prima Pietra di un'animazione che non molto fece, fa, tesoro delle loro intuizioni. Rimandiamo ad altre analisi per rivedere gli sviluppi di quelli che furono i loro eredi, da Cavandoli al Mattotti, via i Bozzetto, Luzzati, Gibba, Gavioli, Manuli, che meriterebbero tutti una trattazione autonoma.
Bibliografia
- Animazione, Giannalberto Bendazzi, vol.1, UTET 2017
- Storia del cinema d’animazione, Gianni Rondolino, Einaudi 1974
- «Oh… Musica moderna!» Hollywood, satira e "modernismo" nella musica di Giuseppe Piazzi per I fratelli Dinamite, Marco Bellano per la rivista "Cabiria", n.178, set./dic. 2014, qui in pdf
0 notes
Photo



n32 di GIOIA 10/08/2017 intervista a Tom Hardy: Vi sembro un duro? https://www.pressreader.com/italy/gioia/textview Tom Hardy. Vi sembro un duro? Sì, verrebbe da rispondere vedendolo al cinema con la divisa da pilota della Royal air force nel kolossal Dunkirk (e prima nei panni del cattivo in The Revenant e ne Il cavaliere oscuro). Ma poi si legge la lettera d’addio al suo cane Woodstock, che ha sc GIOIA10 Aug 2017 Ha la fama di essere un duro, e in effetti quando te lo trovi davanti, con quelle braccia muscolose, la camicia che lascia intravedere i tatuaggi e la mandibola pronunciata, ti mette un po’ soggezio ne. Poi, come per magia, sorride e gli occhi gli si illuminano. E il ghiaccio è rotto. Tom Hardy è così: al cinema gli piace fare il cattivo, come in The revenant, dove è stato lo spietato antagonista di Leonardo DiCaprio in odore di Oscar; sdoppiarsi, come nel thriller Legend; mettere su una montagna di muscoli per diventare Bane, l’arcinemico di Batman in Il cavaliere oscuro - Il ritorno. Ma è lo stesso Tom Hardy che poi, nella vita, si tatua le scritte (in italiano) “padre fiero” sul torace e “figlio mio bello” sul bicipite. E dedica al suo cane Woodstock – che lui stesso aveva salvato da cucciolo in autostrada ed è poi scomparso a sei anni per una malattia nel giugno 2017 – la più commovente e tenera delle lettere d’addio, condivisa in Rete come estremo atto d’amore per il suo «angelo, il miglior amico di sempre». Dal 31 agosto lo rivedremo al cinema, alla sua terza prova con il regista Christopher Nolan: dopo Inception e Il cavaliere oscuro è uno dei protagonisti di Dunkirk, il kolossal bellico – già campione d’incassi al botteghino negli Stati Uniti – ambientato nel 1940, che racconta l’evacuazione della città di Dunkerque, in Francia. Si è detto che Dunkirk sia un progetto che le è personalmente caro. Dove l’ha sentito? ( Sorride, ndr). Voci di corridoio… Be’, in effetti devo ammettere che è vero. E poi, la mia è la generazione che ha ascoltato i racconti dei nonni sulla guerra fin da quando eravamo bambini. Questo film mi ha coinvolto molto ed emozionato tantissimo: spero davvero che piaccia e che diffonda un grande messaggio di memoria collettiva tra il pubblico. È una storia epica e al tempo stesso una grande avventura. Una di quelle vicende che ti prendono, ti tirano dentro e non riesci a uscirne fino a che non si accendono le luci in sala e il film è finito. Si lascia coinvolgere dalla passione nel suo lavoro? Non potrei vivere senza: che vita sarebbe? Lei ha lavorato insieme al regista Christopher Nolan diverse volte. Sì, mi trovo bene con lui, perché affronta tutti i suoi progetti con la stessa mia dedizione, che potremmo anche chiamare irresistibile ossessione. Nel caso di Dunkirk, per raccontare la vicenda Chris ha approfondito così tanto le sue ricerche sugli Anni 40 e ci si è immerso al punto tale che mi pareva di recitare in teatro invece che su un set. Ha scelto un approccio molto particolare, come è nel suo stile: ha voluto raccontare la vicenda da diverse prospettive, cioè dal cielo, dalla terra e dal mare. Io nella storia interpreto Farrier, un pilota della Royal air force, e dunque sono uno dei protagonisti della linea narrativa dedicata all’aria. «Nei personaggi metto sempre una parte di me. È come se i diversi uomini a cui presto il volto di film in film diventassero un’estensione della mia persona» Sta lavorando senza tregua in questo periodo. È anche la star di Taboo, la serie tv della Bbc ambientata nel 1814 in cui interpreta James Delaney, un avventuriero inglese che torna in patria per il funerale del padre e si ritrova a dover difendere la propria eredità ( in Italia in onda su Sky Atlantic, ndr). È un’altra vicenda avventurosa in cui ho creduto fin dal principio, avendo contribuito a crearla dal nulla. Ci ha lavorato molto con suo padre ( lo scrittore, commediografo e comico Edward “Chips” Hard; Tom ha studiato fin da giovanissimo recitazione in diverse scuole di arte drammatica a Londra, dove è nato, ndr). Confesso che adoro lavorare con lui. L’idea del protagonista Delaney è venuta a me e mi ha subito affascinato: spesso le idee nascono all’improvviso, ma mi manca il “contorno”, non so dar loro una direzione. Come in questo caso: amavo questo personaggio, ma non avevo una storia per lui. E allora è arrivato papà ad aiutarmi ( ride, ndr). Dal momento che lo ha creato personalmente, lei avrà sicuramente molte cose in comune con il personaggio che interpreta. Io lo vedo come la metafora di un cambiamento, e in effetti pure a me piace evolvere. Delaney come me ha lati oscuri e altri più luminosi, conosce la felicità ma anche la sofferenza e dunque è capace di inoltrarsi nella sua parte più dark. È complesso, e proprio per questo interessante ( Tom ha sofferto di dipendenza da alcol e droga, da cui è uscito completamente nel 2003 anche grazie al rehab: ha ammesso di aver toccato il fondo, al punto tale da ritenersi fortunato per non essere essere finito male, ndr). Della serie tv è stato anche produttore: pensa di ripetere l’esperienza? Devo confessare che mi ha divertito molto questo tipo di lavoro, forse perché mi piacciono le sfide e amo sondare i miei limiti, ma non medito certo di cambiare professione. Tv e cinema: in quale ambito preferisce lavorare? Amo la tv tanto quanto il teatro e la radio, ma mi piace anche il set. Il vero problema sa qual è? Amo recitare. A volte mi sento come un pesce rosso in un vaso di vetro. Lo sa, i pesci crescono, le loro dimensioni aumentano e quindi a un certo punto per non soffocare hanno bisogno di una vasca più grande dove nuotare. È per lo stesso motivo che ama “esplorare” ruoli diversi? È stato memorabile in Mad Max: Fury Road del 2015: la vedremo ancora nei panni dell’ex poliziotto Max Rockatansky, il ruolo in cui è subentrato a Mel Gibson? Ho firmato per fare tre capitoli della saga, si tratta solo di sapere quando saranno realizzati. Tutti quelli che sono coinvolti nel progetto sono stati superimpegnati, ma sono convinto che ci ritroveremo presto. Ormai ho capito che le cose devono accadere quando è il momento giusto. Adesso che ha raggiunto il grande successo e tutti gli occhi sono puntati su di lei, si sente mai sotto pressione? Tutto può creare un certo grado di stress. Capita quando si hanno delle responsabilità, ma è normale, è la vita. Ogni volta che si investe in prima persona in qualcosa, può essere un film ma anche, per esempio, una relazione, si rischia. E io ho spesso la sensazione che sia colpa mia se qualcosa va male. Cosa caratterizza maggiormente il suo modo di recitare? Nel personaggio che interpreto metto sempre una parte di me stesso, è come se i diversi uomini a cui presto il mio volto, di film in film, diventassero un’estensione della mia persona, perché ci tengo siano il più veri possibile. E a volte mi sento come un testimone dell’evoluzione della storia. Di lei si dice che sia una persona che intimidisce, lo sa? Anche questo è evidentemente parte di quello che sono, è qualcosa che gli altri notano in me e non posso farci nulla. Se solo ci penso mi pare orribile, ma è il gioco dell’esistenza, con cui tutti dobbiamo confrontarci. Lei dà l’idea di essere una persona a cui piace analizzare la natura umana, e farlo in profondità. Mi interessa approfondire la diversità, le sfumature di un determinato comportamento, come le persone differiscano l’una dall’altra. Come si vede in futuro? Resto aperto a tutte le possibilità che mi si presenteranno, ma di certo voglio imparare, migliorare. È come suonare il violoncello: più ci si esercita, più si diventa bravi. Lei dice di essere un duro, ma con sua moglie, l’attrice Charlotte Riley ( che l’ha reso papà nel 2015, ndr) è sempre tenerissimo. E poi con il dolore per la morte del suo cane ha commosso il mondo intero. Confessa di essere anche dolce, quindi? Quello è un altro dei lati più “oscuri” della mia personalità! ( Ride, ndr). G
5 notes
·
View notes
Text
Viva l’Italia: due mostre, Alba e Genova
Un piccolo flash autobiografico: la mia modesta (dico modesta, non falsamente ma con un fine preciso) cultura visiva nasce sui libri della Skirà che mio padre, pittore della domenica e scultore mancato, portava in casa. La mia adolescenza ha avuto due capi: all’inizio su un libro che mi regalò mio nonno tedesco, illustrato però, Robinson Crousoe, il primo che lessi in assoluto, il secondo, sempre che la mia adolescenza abbia avuto una fine, su un quadro su cui mi intestardii per mesi e mesi, perché non riuscivo a produrre quei colori sgargianti che le illustrazioni della famosa casa editrice fornivano delle opere di Derain e dei Fauves in genere. Per casa circolava anche una famosa rivista, Sele Arte, sulla quale Ragghianti raccoglieva articoli vari su architettura, scultura, pittura, ma a volte anche cinema e fotografia, e una meno famosa ma senz’altro più seria, che era intitolata al famoso architetto del Labirinto: quest’ultima si occupava principalmente di arte antica e le sue illustrazioni erano in bianco e nero, mentre sulla prima incontrai Licini. Con il quale la mia adolescenza, se posso aggiungere, ebbe fine (e così anche la modestia).
Perché questa premessa? La risposta sta nel fatto che anni dopo, quando a Parigi visitai non ricordo più che museo e incontrai dal vivo i famosi Fauves, ebbi un flash, lampadina nel cervello, ripiegamento su me stesso, meditazione dolorosa e raccapriccio. Nell’adolescenza non avrei mai potuto ottenere quello che volevo, per una semplicissima ragione: quei colori non esistevano.
Ma esisteva l’arte, quella di Matisse, del primo Braque, di Vlaminck, di Marquet e appunto di Derain, e questa non poggiava sulla vivezza dei colori ma, mi resi conto con sgomento, semplicemente sui loro rapporti. Rimasi di stucco ma, oltre a rivalutare i miei sforzi compositivi adolescenziali dietro il (mio) Mediterraneo, mi resi conto di star facendo due passi avanti, dolorosi ma salutari.
Il primo: l’acquisizione della coscienza che la cultura visiva libresca ha dei limiti invalicabili e che per oltrepassarli occorre marciare gambe in spalla per mettere l’occhio a diretto contatto con le opere, perché questo non sopporta intermediari, che siano letterari o illustrativi. Tutto ciò è costoso e faticoso, ma ha il suo grande rovescio: evita qualsiasi tradimento. Da allora ho acquistato una diffidenza salutare nei confronti di qualsiasi riproduzione, diffidenza che mi porto addosso ancora adesso, anzi soprattutto oggi che Internet e virtuale dilagano e spadroneggiano (sarà questa la ragione per la quale nel mio blog sono rarissime le aggiunte di figure?).
Il secondo, un fatto molto personale: la coscienza che avrei dovuto ricominciare tutto da capo. Un celebre koan di Mummokan recita la storia di un allievo che si prostra davanti a un Maestro e gli chiede di elargirgli la sua saggezza. Il maestro gli fornisce alcuni libri importanti, indispensabili per conoscere il suo insegnamento e gli impone di mandarli a memoria e di tornare solo quando sarà in grado di recitarglieli. L’allievo, dopo un certo tempo (forse era ancora adolescente e le donne lo interessavano in egual misura degli insegnamenti del maestro), torna da lui infarcito e orgoglioso di tutto il suo sapere. Il Maestro, finita la perfetta recitazione, lo licenzia bruscamente, rifiutandogli di accoglierlo fra i propri discepoli. L’allievo esterrefatto non capisce, piange e si dispera e allora il Maestro, mosso a pietà, gli concede una chance: torna da me quando avrai tutto dimenticato.
Ma c’è una terza acquisizione, un terzo insegnamento che ho avuto da tutta questa storia: aleggia come un fantasma un convitato di pietra. Ha nome Skirà.
Altro passo indietro (ancora autobiografico!): l’altro giorno vado ad Alba a trovare mio figlio (e sopratutto la mia deliziosa nipotina, quattro anni, ma che volete, dall’adolescenza mi piacciono le donne) e incappo in una mostra alla Fondazione Ferrero, alla quale ero già stato in passato, per visitare, con un amico che ne possiede un’opera, una ricca mostra di Carrà: Il sogno e la realtà raccoglie le opere più importanti e più famose del Dadaismo e del Surrealismo. Si tratta di una mostra serissima che fa un servizio veramente egregio alla cultura del nostro paese: una specie di pietra tombale sulle rivoluzioni artistiche operate all’inizio del secolo scorso, all’indomani del primo massacro bellico europeo, la prima guerra civile continentale.
Non scherzo, ho detto proprio tombale. Mia nipote girava attentissima a tutti i calembour e alle battute della celebre trouppe, la impressionava vivamente il manichino del teatro meccanico musicato da Satie, aiutata da Tia non riusciva comunque a vedere la donna appoggiata al tavolino di Dalì ecc. Quest’ultimo, padre di famiglia e proccupato dei tempi che stiamo attraversando, probabilmente disapprovava, pensando alla quantità di denaro che la Ferrero, la ditta dove lavora sua moglie, aveva speso per mettere insieme, in provincia, una mostra del genere. Il sottoscritto non era d’accordo: una mostra fatta come diocomanda, con proiezioni, documenti sia grafici che fotografici e ricca delle opere più famose e significative di quell’Avanguardia (il nome, diventato di moda e uno dei caposaldi attorno al quale ha girato la “cultura”, soprattutto visiva, del secolo scorso e mai più abbandonato da chiunque con la patente di curatore si occupi di organizzare la marea di artisti che scorrazzano in giro, risale proprio al periodo rappresentato), una mostra degna della capitale di un grande paese (alludo agli altri) fa onore all’iniziativa privata che offre ai propri dipendenti e non solo, a tutto un bacino di utenza provinciale, un prodotto culturale formidabile, un prodotto che il sottoscritto aveva accostato da adolescente solo sui libri della Skirà. Non ho nemmeno provato a far cambiare idea a mio figlio, a fargli capire che le pietre tombali sono necessarie, che la storia va affrontata seriamente, altrimenti ci insegue e ci bastona: vedere coi propri occhi l’insignificanza delle famose Boutades del Dadaismo e del Surrealismo, constatare la mancanza di mestiere pittorico di uno come Magritte e, al contrario, l’abilità diabolica di uno come Dalì, l’intelligenza finissima di gente come Duchamp o come Man Ray , constatare come l’Avanguardia è soprattutto un prodotto mondano e d’élite di cervello, incontrare, sia pur per caso in mezzo a tanta fuffa, il mistero del manichino di Giorgio De Chirico, non è di tutti i giorni. E ancora una volta, e spero per tutte per quanto riguarda i nostri giovani e i nostri figli, verificare coi propri vergini occhi (“nasciamo liberi e finiamo in ceppi sociali” e, aggiungo io, culturali) la cosidetta Arte d’Avanguardia, poter dimenticare finalmente le immagini e i Discorsi acclusi di libri come quelli del convitato di pietra, non è di tutti i giorni. Non è di tutti i giorni l’occasione unica di liberarsi finalmente di tutti i fantasmi del passato, quelli che ci perseguitano ancora adesso a cento anni di distanza. Non pretendo che mi seguiate, che siate d’accordo che l’abilità pittorica, il talento, l’intelligenza, la finezza dialettica e persino l’immaginazione non bastano da soli a fare arte; ognuno tragga le conclusioni che crede. Una cosa è certa però, lo è per me ma lo deve essere anche per voi: la Skirà ha fatto il suo tempo!
Illuso, bell’ adolescente illuso che ancora sei! C’è qualcosa che non va: quel fantasma non è affatto scomparso, la fa ancora vistosamente da padrone fra noi! Udite, udite:
Mi viene in mente che un paio d’anni fa, a Palazzo Ducale di Genova, la Celebre Casa Editrice organizzò una grande mostra di Modigliani, i cui quadri furono denunciati come falsi (21 su una trentina) e ritirati dalla magistratura: la mostra fu costretta a chiudere e, a sentenza di conferma emessa, a risarcire gli spettatori turlupinati. Qualche osservazione.
Prima: naturalmente in un paese in cui la giustizia fa acqua da tutte le parti attenderemo per anni il verdetto; nel frattempo gli ignoranti che non usano l’organo di cui parlavo poco sopra e si affidano solo alle bagarre di cui approfittano personaggi come Sgarbi continueranno tranquillamente ad essere turlupinati. Seconda, anche solo il dubbio sull’autenticità di opere che sono costate centinaia di milioni dovrebbe consigliare a chi ha organizzato l’esposizione genovese, la Fondazione Skirà Mostre, a ritirare il catalogo e licenziare il curatore (nell’inchiesta è indagato anche il presidente della Fondazione). Terza, in un paese che si rispetti e che ricava dal turismo culturale un introito economico fra i maggiori le sentenze dovrebbero essere immediate, perché affidate a un comitato di esperti adeguatamente pagato, permanente e responsabile, composto sia da stranieri che da italiani (ci sono anche da noi, ci sono). Quarta, l’orchestrazione della truffa (devo aggiungere eventuale per amore della giustizia, ma un’occhiata ai “falsi” senza nemmeno l’aiuto del contatto diretto mi fa propendere per l’ipotesi più grave – anche internet è sufficiente) coinvolge sicuramente molte più persone di quelle tirate in ballo dalla procura: gallerie, privati prestatori, periti ecc. E’ un sistema che è corrotto alla radice e continuerà a prosperare sull’ignoranza generale. E sopra la vicenda genovese sarà messa una pietra. Tombale.
Una cosa è certa, la Skirà continuerà bellamente a farsi gli affari suoi.
Tirem innanz; sono le parole di Amintore Sciesa davanti alla casa di sua moglie prima di essere condotto all’impiccagione dagli austriaci.
Viva l’Italia!
FDL
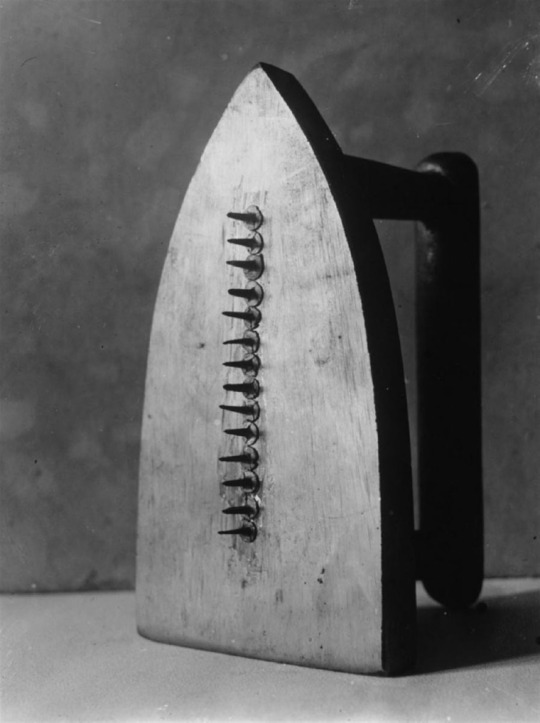
0 notes
Text
[Weekend al Cinema] Il kolossal Dunkirk da stasera nelle sale italiane
[Weekend #alCinema] Il kolossal #Dunkirk da stasera nelle sale italiane
Nella settimana in cui la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia monopolizzerà l’intero interesse dell’universo cinema, le sale italiane accolgono finalmente Dunkirk, il dramma bellico diretto da Christopher Nolan.
Accolto dalla critica come il nuovo capolavoro da Oscar di Christopher Nolan, Dunkirkè pronto all’esame di italiano, e ovviamente è attesa la risposta del pubblico…
View On WordPress
0 notes
Text
Marilyn Monroe
https://www.unadonnalgiorno.it/marilyn-monroe/

Marilyn Monroe è stata la diva per eccellenza, l’icona assoluta della bellezza del ventesimo secolo.
Ha ammaliato il pianeta col suo fascino, alcune indimenticabili scene dei suoi film sono passate alla storia del cinema.
In soli trentasei anni di vita è stata la donna più fotografata, più amata, più criticata, più imitata, più invidiata e forse la più infelice di Hollywood.
Nacque con il nome di Norma Jeane Mortenson il 1° giugno del 1926 a Los Angeles. Non aveva mai conosciuto suo padre e la madre, Gladys Monroe, era affetta da gravi disturbi mentali, che la costrinsero a frequenti ricoveri in un ospedale psichiatrico.
Per buona parte della sua infanzia, ha alternato permanenze in orfanotrofi o affidi a famiglie temporanee a turbolenti ritorni a casa. Quando alla madre fu diagnosticata la schizofrenia, la piccola Norma Jeane venne presa in tutela dalla sua migliore amica, Grace McKee, archivista di pellicole alla Columbia Pictures, fu forse da lei che apprese l’amore per il cinema. Era una ragazzina con evidenti carenze di affetto e bisogno di sicurezza, mentre era al liceo conobbe il suo primo marito James Dougherty, che sposò a soli 16 anni, nel 1942 e da cui si separò dopo quattro anni.
Trovò un impiego presso un’industria aeronautica produttrice di paracaduti. Fu lì che il fotografo David Conover, impegnato a documentare il lavoro femminile nel periodo bellico, notò la sua incredibile bellezza e la convinse a intraprendere la carriera di modella. Da quel momento, sotto la guida di un altro fotografo, Andrè de Denes, cominciò a comparire sulle copertine delle riviste. A vent’anni, nel 1946, venne messa sotto contratto dalla Fox e le si aprirono le porte di Hollywood. Divorziata, si schiarì i capelli e cambiò il suo nome in Marilyn Monroe, il cognome era quello da nubile della madre.
Ha iniziato a fare la comparsa in vari film, per poi conquistare piccole parti che la lanciarono nel firmamento del cinema. Giungla d’asfalto, Eva contro Eva, Monkeys Business e altri ancora.
Nel 1952 ottenne il suo primo ruolo da protagonista in La tua bocca brucia. Il successo mondiale è arrivato nel ’53 con Niagara.
Con Come sposare un milionario e Gli uomini preferiscono le bionde, si è confermata una delle star più amate dal pubblico. Seguirono altri clamorosi successi.
Nel 1954 Marilyn Monroe ha sposato il famoso giocatore di baseball, Joe DiMaggio, da cui ha divorziato in meno di un anno e iniziato a collezionare una serie di profonde delusioni sentimentali che la trascinarono sempre più in un grande vuoto esistenziale.
Dopo la separazione si è trasferita a New York per studiare all’Actor’s Studio. In quel periodo ha conosciuto Arthur Miller, affermato commediografo, e affascinante intellettuale che vantava la rappresentazione delle sue commedie in tutto il mondo. I due si sposarono nel 1956. In quel periodo ottenne una nomination al Golden Globe per Fermata d’autobus.
Nel 1957 l’attrice ha fondato, con l’amico fotografo Milton Green, la sua casa di produzione cinematografica, la Marilyn Monroe Productions, con cui ha girato un unico sfortunato film Il principe e la ballerina al fianco di Laurence Olivier.
Due anni dopo si è ripresa con la sua partecipazione all’esilarante commedia di Billy Wilder A qualcuno piace caldo, personaggio stampato indelebilmente nella mente degli spettatori.
Marilyn aveva bisogno di continue conferme e attenzioni e iniziò varie relazioni con altri uomini, che infiammarono i tabloid di gossip e pettegolezzi.
Nel 1962 ha ricevuto il Golden Globe come migliore attrice. Veniva finalmente riconosciuto il suo talento e carisma. Ma fu comunque una magra soddisfazione. Aveva iniziato una relazione segreta con il presidente degli Stati Uniti John Fitzgerald Kennedy che la trattava come un gradevole passatempo e nulla più.
La sua instabilità emotiva si aggravava, forse proprio a causa delle tormentate storie d’amore in cui si gettava. Ha cominciato a rifugiarsi nell’alcool e nei barbiturici e a entrare e uscire dalle cliniche.
Nel 1962 è uscito il suo ultimo film, Gli spostati scritto per lei da Arthur Miller, con cui nello stesso anno, ha divorziato.
Venne cacciata dal set di Something Gotta Give perché era diventata ingestibile, si presentava ubriaca, non rispettava gli orari, era fuori controllo. Poco confortata da una relazione con Robert Kennedy, più affettuoso del fratello, la diva è precipitata definitivamente nel gorgo della depressione.
Il 5 agosto del 1962 è stata ritrovata senza vita, senza vestiti e con la cornetta del telefono in mano nella sua camera da letto. Il referto fu di suicidio per un’overdose di barbiturici, ma molte cose non erano chiare nella ricostruzione degli eventi, tanto che ancora oggi la sua morte è uno dei misteri irrisolti di Hollywood.
Ciclicamente ritornano le ipotesi di omicidio, di servizi segreti, di vendetta a causa della sua relazione coi due uomini più importanti del tempo. Ma forse la verità non la sapremo mai.
Nel suo testamento si lesse che aveva lasciato il suo patrimonio (un paio di milioni di dollari) alla scuola di recitazione di Lee Strasberg, alla sua psicoanalista e alle cure per la madre malata. È stata sepolta al Westwood Memorial Park di Los Angeles.
Della bellissima bambina Marilyn Monroe, come l’aveva chiamata Truman Capote, ci restano migliaia di mostre, di sue immagini, i suoi film, i segreti che si è portata dietro.
È stata un’attrice e una cantante straordinaria. Unica a suo modo. Una donna bellissima e sensuale come poche, molto generosa ma con un mal de vivre che l’ha accompagnata per tutta la sua breve esistenza.
Su di lei si è detto e scritto di tutto. Che fosse impossibile lavorarci insieme. I ritardi. Le battute mai imparate. Gli infiniti ciak. La testa sempre altrove, persa nei suoi vortici. La sua sensazione di sconforto e di sostanziale solitudine. È stata ricordata in libri, film, retrospettive. Ancora si scrivono articoli su come viveva, cosa mangiava, come vestiva. I suoi abiti di scena sono stati battuti all’asta e rappresentano importanti cimeli. La sua vita è stata setacciata in migliaia di aneddoti, indiscrezioni, racconti. È stata donna più desiderata eppure la più infelice. Comunque, un mito intramontabile.
0 notes